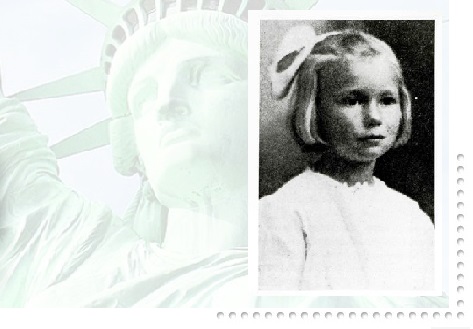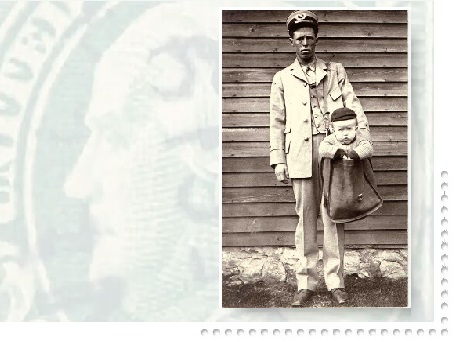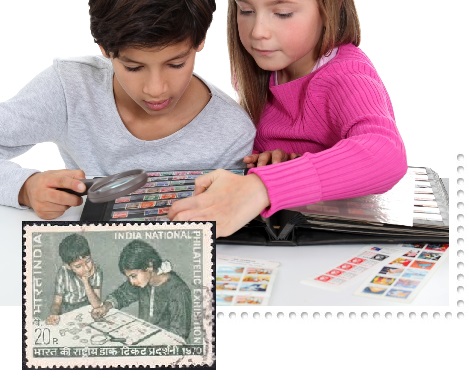Articolo originariamente pubblicato il 12 marzo 2018
Rieditato per questo sito il 14 settembre 2021
Non c'è nulla da fare, gira e rigira, lo scalino
generazionale impone sempre un surplus di allenamento nel cercare di trasmettere
e di condividere la propria passione di "raccoglitore".
Ne avevo già disquisito in un mio post dal titolo, appunto, "incontri generazionali lungo il percorso", nel
quale raccontavo di impegno e difficoltà nel coinvolgere i figli nella mia
passione, senza forzature s'intende, ma con l'obiettivo, almeno, di offrire
loro l'immagine di un genitore che non rappresentasse un pregevole pezzo di
modernariato, ma proiettasse il senso del collezionare non solo come un
incontrollabile desiderio di accumulare cose, ma come il piacere di
viaggiare nello spazio e nel tempo e catalogare e conservare schegge del
nostro passato, frammenti di storia, il ricordo di eventi e personaggi persi
nell'oblio della topografia urbana, ma anche di ampliare il proprio orizzonte
culturale semplicemente cercando di capire cosa un francobollo, un annullo od
una vecchia missiva volevano celebrare o comunicare.
Certo che sono lontani i tempi in cui, come racconta La Stampa in un articolo dal titolo "Colleziona,
colleziona: qualcosa resterà", Italo Calvino fu in qualche modo
folgorato dal collezionismo. Lo scrittore, recatosi a un’esposizione parigina dedicata alle collezioni inconsuete e strane, scoprendo una curiosa raccolta di contenitori di sabbia delle più svariate spiagge del mondo scriverà "Il vero collezionista è un bambino che ha appreso la difficile arte di abitare nelle cose che ha raccolto, senza fine".
Siamo dunque ormai lontani da quella capacità di raccogliere, nel
difficile, ma necessario confronto con una nuova generazione che ascolta
musica per cancellarla subito dopo, che fatica ad acchiappare il senso
del conservare per ricordare, conservare per trasmettere. Walter Benjamin, filosofo, scrittore, critico letterario e traduttore tedesco, amava dire "per
il collezionista, quello autentico intendo, il collezionista come deve
essere, il possesso è il rapporto più profondo che in assoluto si possa
avere con le cose: non come se le cose fossero viventi in lui, piuttosto
è egli stesso che abita in loro" e continuava affermando che "i
collezionisti sono fisiognomia del mondo delle cose. È sufficiente
osservarne uno e badare a come tratta gli oggetti della propria vetrina.
Si direbbe che appena li tiene in mano appaia ispirato da essi, abbia
l’aria di un mago che attraverso di essi guardi nella loro lontananza".

Tornando a
noi, accade che, nel molto orgoglioso tentativo di mostrare ai
"millenium" domestici la mia sezione dedicata ai servizi
della Repubblica, mi trovo innanzi quei sorrisetti ironici,
leggermente beffardi, rivolti a me ed ai quei piccoli dentelli, stretti nel
loro minuscolo formato pensato per spezzarsi tra plico e bollettino. A nulla
sarebbe valso spiegar loro che il servizio dei pacchi postali,
relativamente al periodo repubblicano, fu riattivato fra il luglio e l’agosto
del 1946 e che quei piccoli francobolli erano testimoni della fine della
Seconda Guerra Mondiale per gli italiani. Non solo! Essi rappresentarono un
elemento importante della ricostruzione e della ripresa economica del Paese,
essendo il vettore di merci e materiali che raggiungevano le famiglie in tutta
la penisola, portando loro beni di prima necessità, aiuti materiali di
conforto. Nemmeno la mia più ricca raccolta dedicata alla ricostruzione, che ho
collocato nella sezione chiamata "la collezione del
tricolore", avrebbe potuto catalizzare un interesse attivo da
parte dei miei amati figli. Allora? Come sempre è stato necessario ritarare
il punto di vista.
Per farlo mi
sono rammentato di una storia che avevo letto qualche tempo fa sul sito
dell'autorevole Smithsonian National Postal Museum, una storia
che riguardava proprio il servizio dei pacchi postali. Una cronaca di postalità
conosciuta ai più, ma che certamente vale la pena di raccontare nuovamente,
così come ho fatto con i miei ragazzi, quelli che vivono nell'epoca dell'usa e
getta e del mondo in cloud e che ignoravano che, c'era una volta...
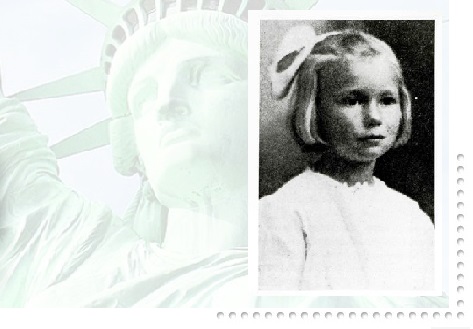
C'era una volta una bambina, di nome faceva May
Pierstorff. Era bionda e tra i capelli teneva legato un bel fiocco, a
dare ancor più grazia a quel viso angelico, tipico di tutti i bambini
del mondo. Difficile pensare alla piccola May alla stregua di un "pacco
postale", ma questa è la verità! La bambina è probabilmente il più famoso pacco postale della storia di tale servizio. Il
19 febbraio del 1914, la giovanissima May, poco prima del suo sesto
compleanno, fu
letteralmente "spedita" dalla casa dei suoi genitori a Grangeville,
nell'Idaho, recapitata ai suoi nonni a poco più di settanta miglia di
distanza per, incredibile a dirsi, per soli 53 centesimi
di francobolli. I genitori di May, infatti, avevano deciso di utilizzare il servizio di pacchi postali, iniziato solo l'anno prima.
Nei primi anni di questo servizio, i clienti ed i funzionari postali
ceravano ancora di comprendere i vantaggi ed i limiti di questo
innovativo servizio offerto dal sistema postale americano.
Qualcuno si affretterà a dire che un caso
sensazionalistico non fa la storia, ma la verità, documentata da Nancy
Hope, storica e curatrice delle raccolte filatelico postali dello
Smithsonian, è davvero un'altra. La piccola May non fu l'unica bambina che i genitori affidarono al servizio di pacchi postali del Dipartimento delle Poste a stelle e strisce. Non a portalettere qualunque, s'intende, ma
a
fidati impiegati postali con cui affrontare il viaggio in tutta
sicurezza, quasi fossero accompagnati dal diritto di raccomandazione con
tanto di assicurata appiccicata in fronte, May, infatti, fu recapitata
da un parente che lavorava sui
treni della posta ferroviaria statunitense, che probabilmente già aveva
metabolizzato l'esperienza di un altro postino che, nel gennaio del
1913, prese in carico nella sua bolgetta il
primo bambino "spedito" negli Stati Uniti da
Batavia, Si trattava del figlio dei coniugi Beauge di Glen Este che fu
trasportato dalla corriera del sistema postale rurale "Vernon Little"
alla nonna che abitava a
circa un miglio di distanza. I
genitori del ragazzo pagarono solamente 15 centesimi per i francobolli
e, siccome i figli non hanno prezzo, lo assicuravano anche per la cifra
di 50 dollari. Dopo il maschietto fu la volta di una bambina, figlia dei
signori Savis di Pine Hollow,
località della Pennsylvania. La piccola fu spedita il 27 gennaio. Presa in carico dal "corriere rurale" James Byerly
da Sharpsville, fu recapitata assolutamente indenne quello stesso
pomeriggio ai parenti che vivevano a Clay Hollow. La baby spedizione costò ai suoi genitori 45 centesimi.
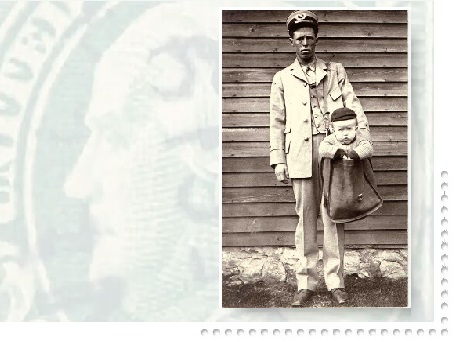
Tale entusiasmo per il nuovo servizio di pacchi postali "made in USA"
provocò un certo sconcerto tra i funzionari del sistema postale
americano. Un disorientamento che spinse il Direttore Generale Albert
Sidney Burleson, il quarantacinquesimo reggente delle Poste degli Stati
Uniti, a varare una norma che stabiliva che i bambini non potevano
essere considerati missive o pacchi.
Ciò
però, evidentemente, non fu sufficiente a frenare la voglia o la
necessità di spedire, spendendo solo qualche centesimo, i propri figli
da una parte all'altra del Paese. Le cronache raccontano che il 1915 fu
l'anno in cui i "pacchi postali bambini" toccarono il loro culmine. Nel
mese di marzo, Charles Hayes, del servizio di posta rurale di Tarkin,
nel Missouri, trasportò la figlia dei coniugi Combs, la dolce Helen,
affrancata alla stregua dei pacchi postali, per la modica cifra di 10
centesimi. Il portalettere consegnò Helen alla nonna, la cui abitazione
non era però molto distante. Nell'autunno dello stesso anno Maud Smith,
di tre anni, ha "viaggiato" da casa dei nonni a quella della sua
famiglia a Jackson, nel Kentucky. Tale spedizione fu però oggetto delle
cronache locali e il servizio giornalistico che ne nacque accese una
inchiesta interna alle Poste americane, che stabilirono, in modo chiaro
ed inequivocabile, che tale procedura era una chiara violazione delle
regole postali. Fu l'ultimo caso documentato di "baby pacco postale".
Il record per il trasporto sulla maggiore distanza, ci ricorda Nancy
Hope nel suo articolo, va però accreditato ad Edna Neff, di sei anni. Ha
viaggiato dalla casa della mamma a Pensacola, in Florida, sino
all'abitazione del papà, a Christainburg, in Virginia. Stante il suo
ridottissimo peso l'affrancatura costò ai genitori solamente 15
centesimi.
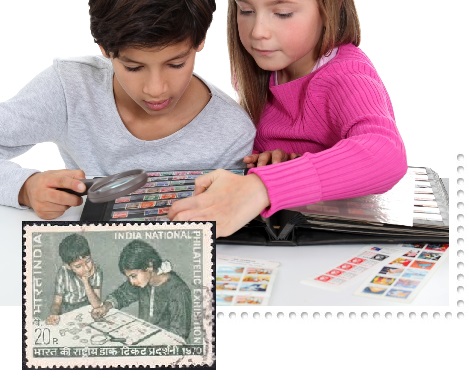
Il "c'era una volta" finisce qui. Una
storia già raccontata, ma che mi ha permesso di vedere un sorriso sul
viso dei miei figli che forse, ogni volta che rivedranno quei piccoli
francobolli dei pacchi postali della nostra Repubblica a riempire le pagine del mio album,
si ricorderanno di quei bambini finiti nella capiente bolgetta del
portalettere. Chiudo con un'ultima citazione di Walter Benjamin; "ciò
che nel collezionismo è decisivo, è che l’oggetto sia sciolto da tutte
le sue funzioni originarie per entrare nel rapporto più stretto
possibile con gli oggetti a lui simili. Questo rapporto è l'esatto
opposto dell’utilità e sta sotto la singolare categoria della
completezza. Cos'è poi questa «completezza»? Un grandioso tentativo di
superare l'assoluta irrazionalità della semplice presenza dell'oggetto
mediante il suo inserimento in un nuovo ordine storico appositamente
creato: la collezione".
Bibliografia essenziale
- Marco Belpoliti, Colleziona,
collezione: qualcosa resterà; La Stampa, 07.07.2015
- Walter Benjamin, Opere complete.
Vol. 1: Scritti 1906-1922; Einaudi, 2008
- Italo Calvino, Collezione di
sabbia; Mondadori, 1984
- Nancy Hope, Very Special
Deliveries, Smithsonian National Postal Museum, 19.02.2013