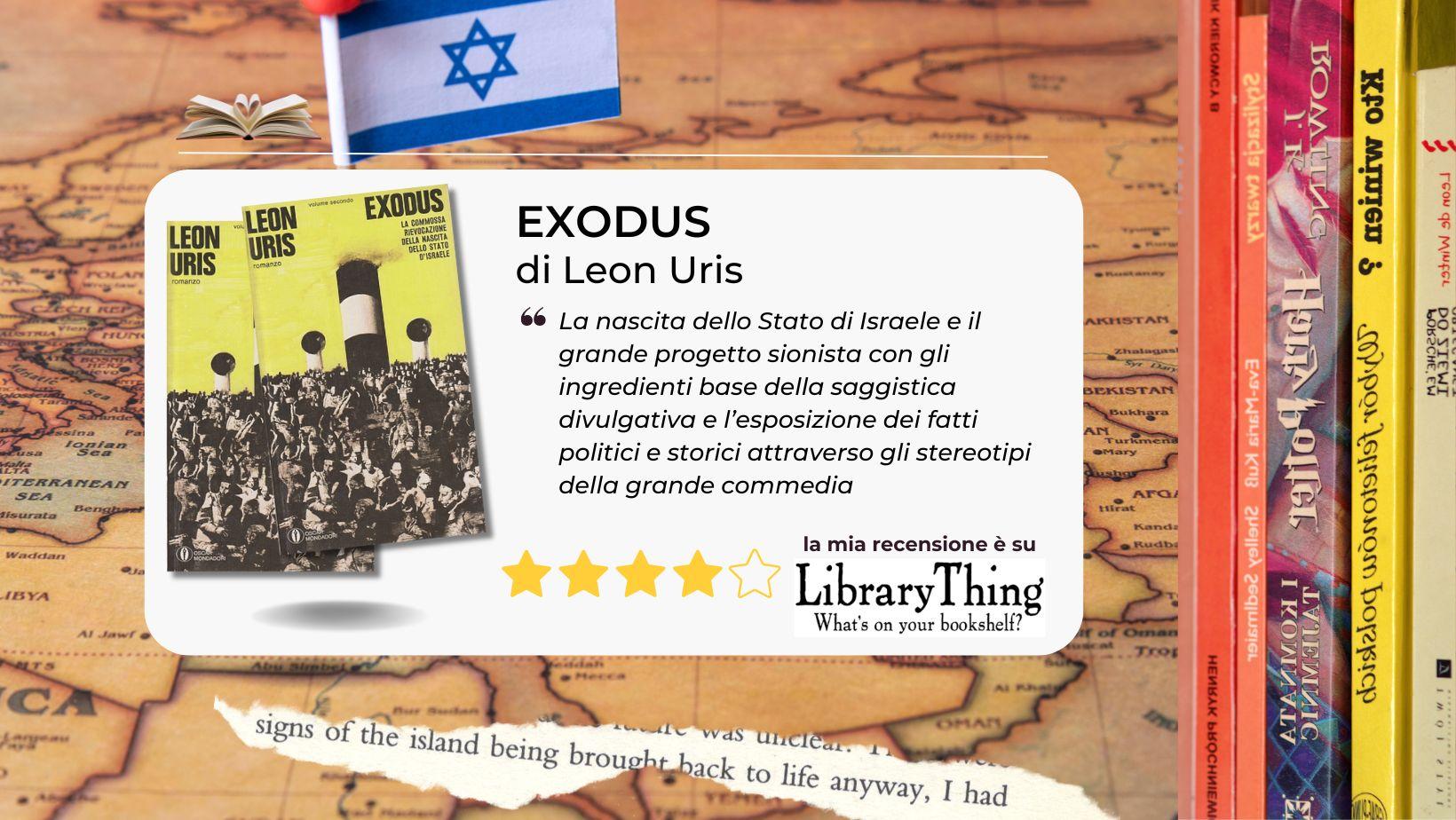La nascita dello Stato di Israele e il grande progetto sionista con gli occhi di Leon Uris in "Exodus"

Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:

Scrittore prolifico di romanzi di successo pregni dell'interpretazione sionista della storia ebraica moderna, Leon Uris (1924 - 2003) nel 1958, anno di pubblicazione di “Exodus” (Mondadori, 1961), era già stato un corrispondente della guerra in Medioriente tra arabi ed israeliani. L’enciclopedico lavoro di questo autore (quasi 750 pagine nella prima edizione Oscar Mondadori raccolte in due volumi indivisibili) ha catturato attenzione ed immaginazione di migliaia di lettori, tanto da essere diventato un best seller mondiale, secondo solo a “Via col vento” e tradotto sin da subito in oltre 60 lingue. Il regista Otto Preminger nel 1960 ne trasse persino un film in cui Paul Newman recitava la parte di Ari Ben Canaan, uno dei protagonisti principali, ispirato, si mormora alla vita ed alla storia di Yitzhak Rabin.
Senza entrare nel merito del “da che parte sta la storia”, fermo il postulato che in questa ormai perpetua lotta tra palestinesi e israeliani il bene ed il male non stanno per intero da nessuna delle due parti, credo che questo sia un buon libro, offra più spunti di riflessione e che vada quindi letto. Con le dovute pause s’intende, data la sua mole. Sfogliato e consumato indipendentemente da come ci si è schierati nella contrapposizione tra le ragioni delle due parti in causa, perché esso nasconde tra le sue pieghe qualche risposta alle domande che inevitabilmente ci si pone leggendo narrazioni quali “Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa (2011 Feltrinelli) oppure “Fuga dall’inferno. Una storia palestinese” di Mischa Hiller (Newton, 2010). La mia valutazione stellata si riferisce dunque più all'aspetto e all'intreccio narrativo, essendo questo un romanzo, piuttosto che al chiaro orientamento filo sionista dell'autore.
La scrittura, nonostante la densità di parole, di persone, eventi, scivola abbastanza fluida. Chi non è riuscito ad andare oltre le prime pagine, evidentemente non ha capito sin dalla scelta sullo scaffale, di cosa questo libro parlasse. Uris sceglie, infatti, un episodio che si colloca, nella storia di Israele, potremmo dire in un’epoca di mezzo, quella dell’immediato secondo dopoguerra, quella che per molti è l’inizio di tutto, ma che di fatto, e sarà questo libro a rivelarlo, è tutt’altro che il principio. Exodus (in memoria dell’esodo biblico) è il nome di una nave, una “carretta del mare” che, nel 1947, alla vigilia della nascita dello Stato di Israele, è riattata per far “evadere” dai campi di internamento di Cipro (in cui gli inglesi rinchiudevano gli ebrei per non farli approdare nel loro bel Protettorato di Palestina) un gruppo di bambini ebrei verso la “Terra Promessa”. La partenza della nave è ostacolata dagli Inglesi, ma essa riuscirà comunque a salpare, grazie al coraggio di alcuni personaggi, primo tra i quali Ari Ben Canaan, personalità su cui fa perno l’intero romanzo.
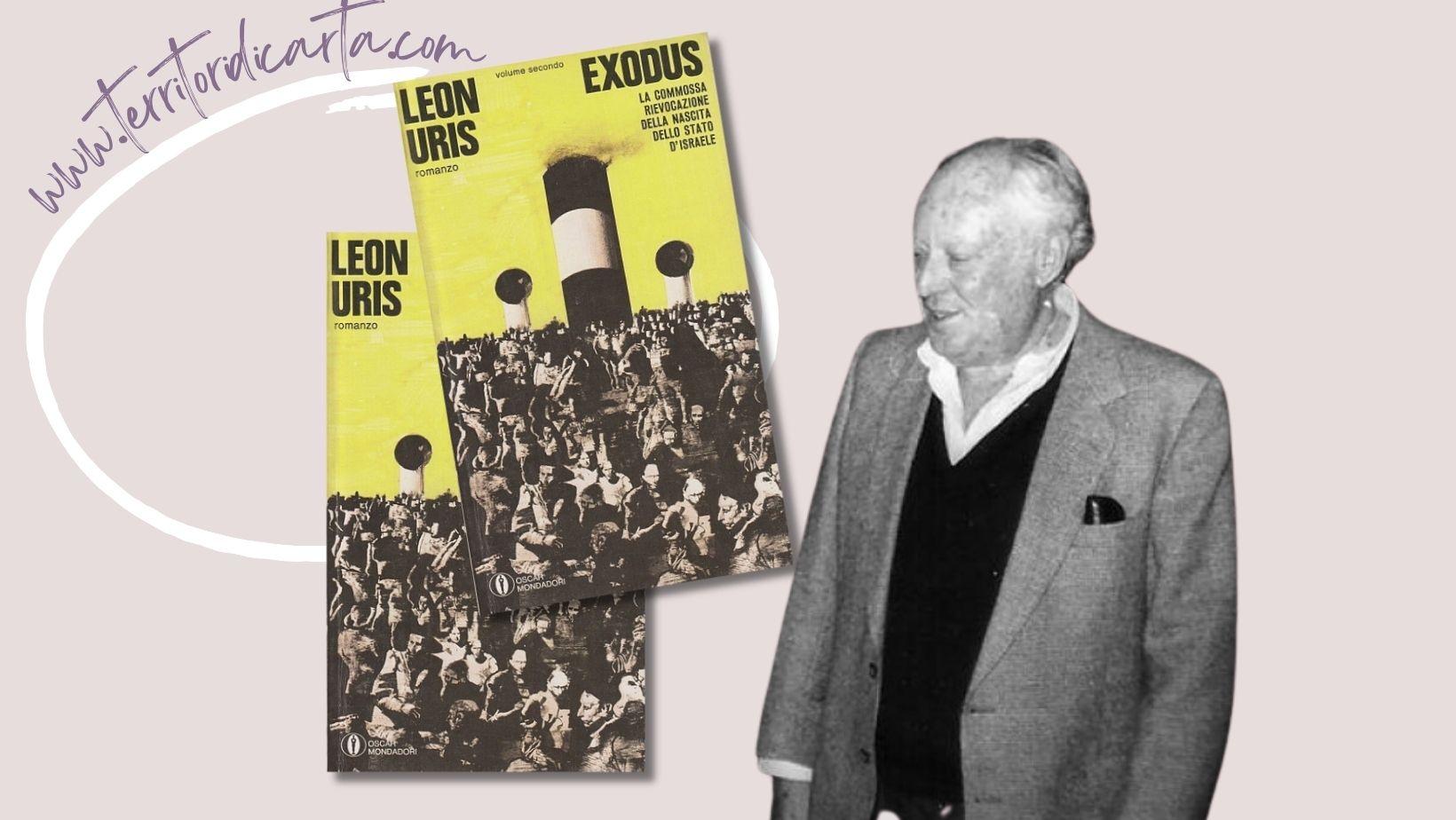
Uris fa bene il suo mestiere e non cade nel tranello della redazione accademica di un saggio storico, ma affida la sua idea della saga popolare e nazionalista ad uno stile che tanto ci riporta ai libri di Dominique Lapierre e Larry Collins, navigati giornalisti d’inchiesta noti al grande pubblico per libri quali “Gerusalemme! Gerusalemme!” (Mondadori, 1972) o “Parigi brucia”. La vicenda dell’Exodus trae ispirazione da eventi realmente accaduti, ma quei fatti l’autore li usa soprattutto per costruire l’intera epica della storia d'Israele. Il viaggio della nave verso la Palestina dunque, diventa il pretesto sul quale Uris tesse il suo racconto. Una storia che si dirama in infinite direzioni seguendo le vite, le sofferenze, le gioie, le aspirazioni dei personaggi che animano la vicenda Exodus, Uomini e donne le cui vite romanzate, ispirate certamente ad esperienze reali, attraversano complesse saghe familiari e tracciano quel percorso che inizia con i feroci pogrom nella cosiddetta "zona di residenza" ebraica in Russia, nel quarantennio compreso tra il 1881 e il 1921, e quelli che infiammarono l’atmosfera polacca e dell’est europeo. Persecuzioni che diedero vita alla prima ondata di emigrazione degli ebrei verso la Palestina, un “ritorno” iniziato dunque assai prima dell’Olocausto nazista.
Leon Uris amalgama gli ingredienti base della saggistica divulgativa con l’esposizione dei fatti politici e storici utilizzando gli stereotipi della grande commedia con cui veste i suoi personaggi di emotiva drammaticità o di esaltazione patriottica. Lo fa attraverso dialoghi semplici che arrivano in modo diretto al lettore. Scivola, con disinvoltura, sulla linea del tempo. Passa dalla Francia di fine ‘800, citando Alfred Dreyfus e con lui Thedor Herzl, alla nascita del sionismo. Ci parla del Fondo Nazionale Ebraico che acquistava terreni in Palestina e poi cambia scenario con la storia familiare dei fratelli Rabinsky, pionieri della colonizzazione, giunti a piedi come Mosè nella terra dei padri. Racconta dei patimenti dei campi di concentramento, dello sterminio di massa, delle menti sconvolte dei sopravvissuti, ma anche della dichiarazione Balfour e del tradimento continuo, costante, perseverante dell’Inghilterra. Ma, intendiamoci bene, non lo fa attraverso una narrativa astratta trasfusa di ricostruzioni storiche. Egli punta più all’intimismo esperienziale dei personaggi che animano il libro per coinvolgere chi legge. Così riesce a stimolare, avvincere e commuovere in modo sorprendente.
E in questa commozione che Leon Uris astutamente cerca di farci intravvedere il limes tra buoni e cattivi. Salvo qualche sporadico episodio di “arabi buoni” (spazzati però via poi dagli eventi che si susseguono) ce ne sono pochi, anzi pochissimi. Gli arabi di “Exodus” sono in maggioranza inaffidabili, doppiogiochisti, truffaldini, codardi, maldicenti, pigri, assassini, ladri e stupratori. Oppressori degli ebrei già più volte oppressi. Uris ci mostra il ghetto di Varsavia, il ponte aereo di Berlino, la campagna del Sinai, massacri e scorribande musulmane, la causa sionista, offrendocene quasi (benché il libro sia stato pubblicato nel 1958) il ritratto di un’identità ebraica moderna in cui però il lettore informato faticherà a scorgere, soprattutto nella seconda parte del romanzo, il pio ebreo non violento che sa accettare il destino che Dio ha scelto per lui. C’è una dicotomia opprimente tra l’ebreo perseguitato da secoli e l’israeliano che rivendica il diritto d’esistere come tale e non a caso ho utilizzato i due termini.
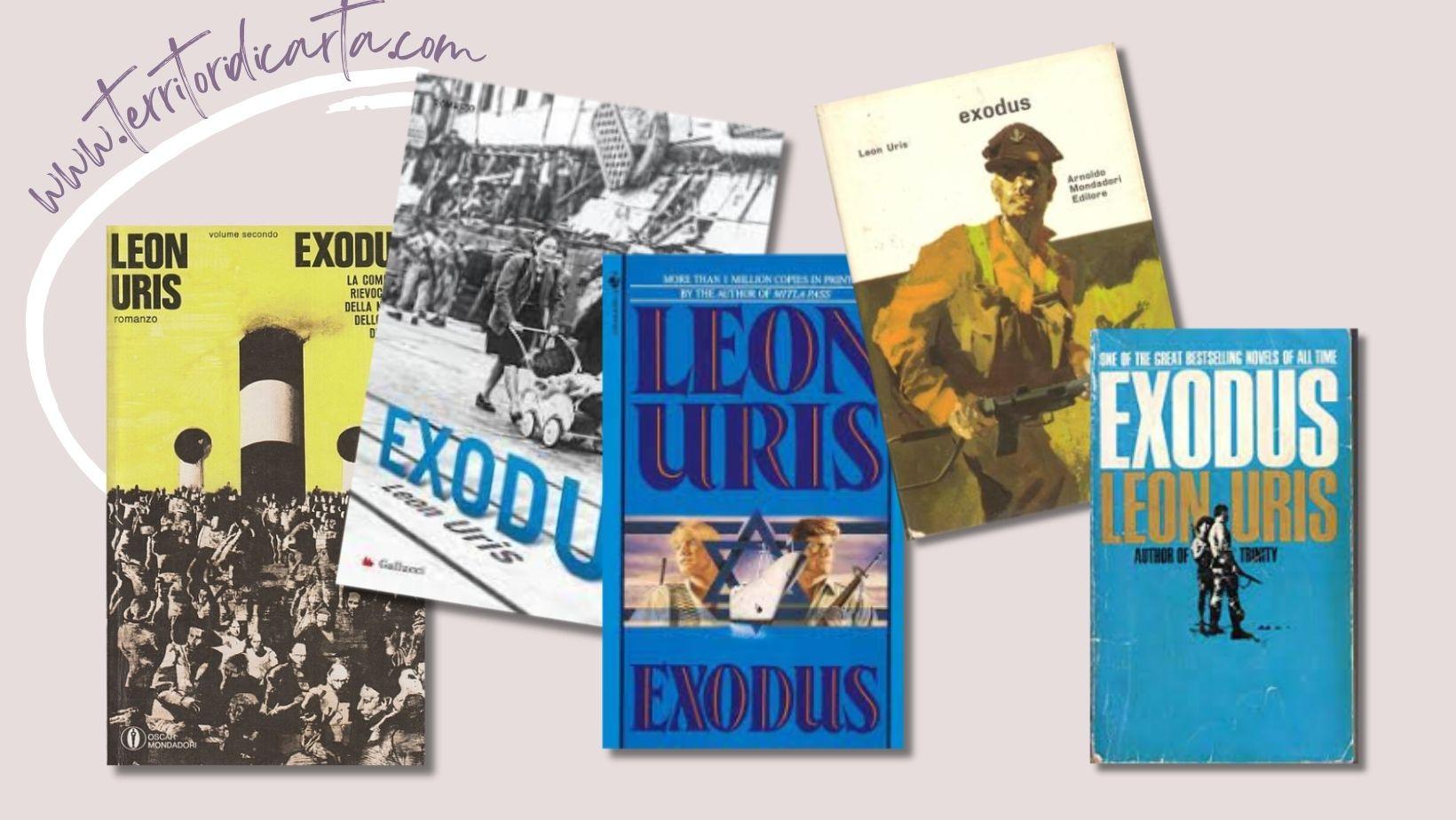
In tutto ciò, tra le righe, ho colto una risposta ad un quesito che nell’odierna geopolitica del Medio Oriente più volte mi sono posto. Come è possibile che chi è stato oggetto di una persecuzione tanto disumana da dover coniare un termine per descriverla, possa a posteriori adottare un comportamento altrettanto persecutorio nei confronti di un altro popolo? Quanto “Exodus” racconta potrebbe offrire già a metà del libro una risposta: l’esasperazione, la sofferenza, la sovrapposizione di eventi persecutori reiterati nel tempo? Non basta. Suona come una semplificazione tutt’altro che esaustiva, anzi sarebbe forse cedere senza lottare alla capacità persuasiva di Uris circa il teorema post olocausto, ancora oggi adottato per rispondere ad ogni critica ad Israele con l’accusa di antisemitismo. Mi sono persuaso invece, nel leggere di queste oceaniche masse di bambini senza più genitori (migliaia) e traumatizzati al punto da esser orfani di se stessi, che tali maree umane piombate in Palestina dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiano rappresentato la cellula staminale su cui si è poi sviluppata la società israeliana attuale. Una cellula cresciuta e replicata, ma sarebbe meglio dire adottata e istruita, in kibbutz militarizzati ed assediati, in cui la formazione era di tipo paramilitare, alimentata dalla cultura fortemente nazionalista della terra promessa rogitata per volere divino dai dogmi religiosi che hanno eletto questa generazione a popolo scelto dalla divinità. Ma questa è chiaramente una mia idea, che poco ha a che vedere con quello che sarà il giudizio della Storia.
Certo è che la ricchezza di contenuti pare confermare quanto l’autore ha scritto del suo lavoro: di aver viaggiato per dodicimila miglia all'interno di Israele ed aver intervistato oltre un migliaio di persone, anche se, come qualche critico ha affermato, Uris non ha mai detto quante di loro fossero palestinesi. Di sicuro qualche americano lo ha ascoltato, quanto perché nel libro due personaggi chiave (il giornalista Mark Parker e l’infermiera Kitty Fremont) sono il ritratto perfetto dell’americano buonista votato alle cause altrui, ma soprattutto devoto alla causa dello stato ebraico. C’è persino l’anziana ed iperattiva filantropa sionista, Harriet Saltzman organizzatrice della Alyat Giovanile (giusto per ritornare agli orfani), che tanto si fatica a non associare alla benefattrice d’oltreoceano Rebecca Seizling, facoltosa ebrea, simbolo del generoso ed interessato sionismo a stelle e strisce che compare in “Adamo risorto” di Yoram Kaniuk (Theoria, 1995). Libro, quest’ultimo, in cui l’interprete Adam Stein, a cui fu risparmiata la camera a gas per poter intrattenere come “pagliaccio” migliaia di altri ebrei mentre marciavano verso la morte, tanto ci ricorda Dov Landau, scampato ai lager e risorto tra le file degli audaci combattenti israeliani di “Exodus”.
Da leggere quindi. Lasciandoci trasportare sull’onda dell’emozione. In fondo è questo che chiediamo più d’ogni altra cosa ad un libro. Ma senza cadere nei tranelli di una propaganda che, volenti o nolenti, quando si parla di Palestina strizza sempre l’occhio per una parte o per l’altra. Una sola certezza su cui tutti saranno d’accordo alla fine del libro: la figura peggiore la fanno senza alcun dubbio gli inglesi.