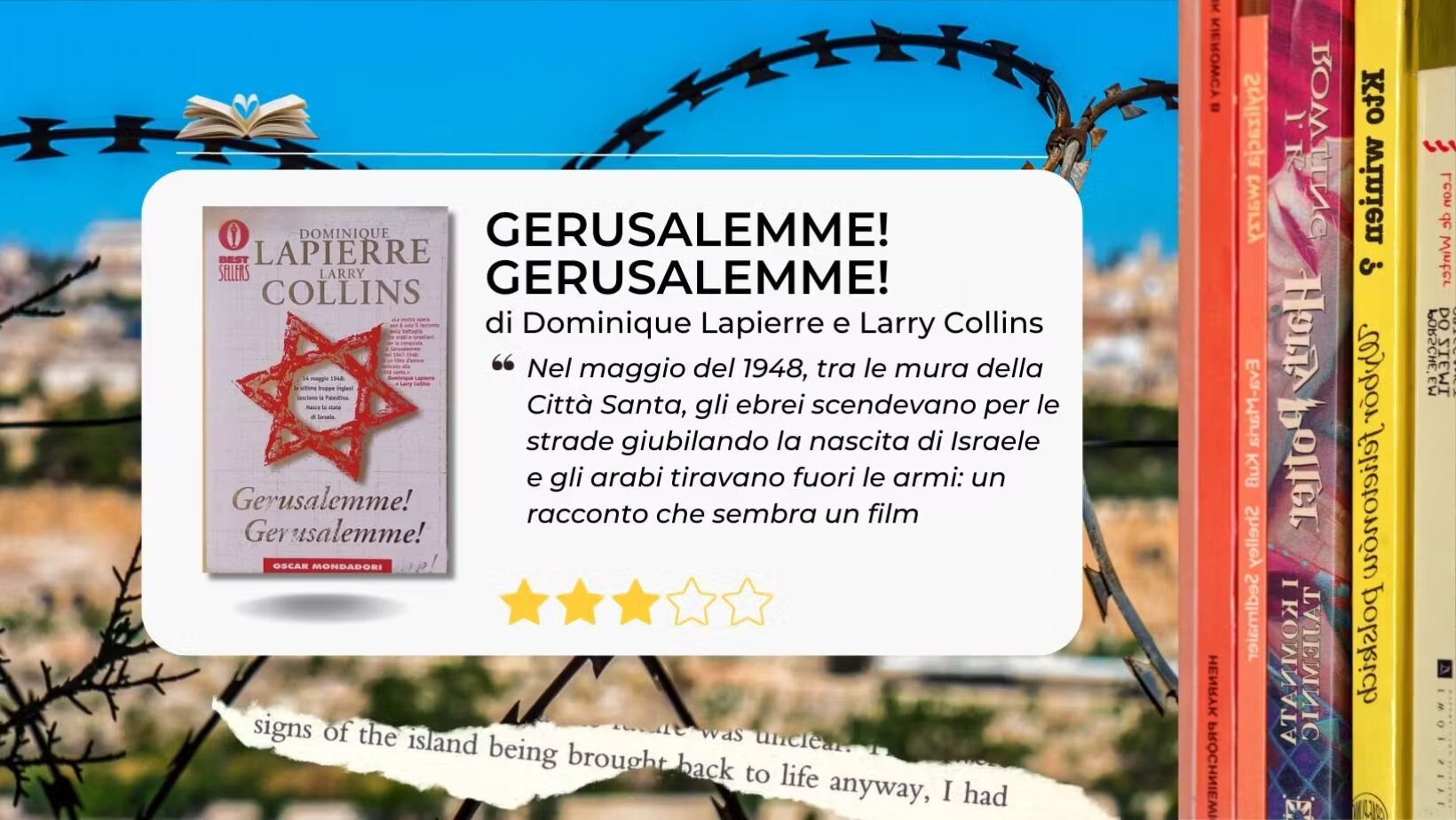⭐ Sufficiente⭐ ⭐ Più che discreto⭐ ⭐ ⭐ Buono⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ EccellenteLa mia valutazione su questo libro:



Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:



⭐ Sufficiente⭐ ⭐ Più che discreto⭐ ⭐ ⭐ Buono⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ EccellenteLa mia valutazione su questo libro: Non è semplice formulare un invito alla lettura per “Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa (2011 Feltrinelli, ora in Universale Economica Feltrinelli - traduzione Silvia Rota Sperti). Non lo è mai per un libro che coinvolge fortemente a livello emotivo e lo fa toccando dei nervi scoperti della nostra storia. Della nostra e di quella di due popoli, gli abitanti dello stato di Israele e quelli della terra di Palestina, le cui vicende, in un disegno geopolitico non sempre volutamente chiaro e ben delineato si sono intrecciate e ci hanno spesso coinvolto emotivamente, tanto da spingerci a fasi alterne ad ergersi a ruolo di giudice, ad emettere sentenze sommarie, a trarre affrettate conclusioni. Un primo grande pregio questo libro lo ha: non si limita a farci piangere, arrabbiare, a provare un bruciante senso di impotenza, ma ci obbliga a riflettere e, soprattutto, ci impone di documentarci, apprendere, approfondire per capire il perché. Nata da una famiglia palestinese fuggita dalla propria terra nel pieno della Guerra dei Sei Giorni, Susan Abulhawa, ha trascorso la sua infanzia in un orfanotrofio di Gerusalemme. Si è poi trasferita negli Stati Uniti e da anni si occupa dei bambini dei Territori occupati, scrivendo saggi, articoli, dando vita ad una associazione benefica. La sua scrittura è viva e graffiante e, pur in un racconto a metà tra romanzo e cronaca (ben documentata), ella ci regala un drammatico, lacerante, dirompente spaccato di ciò che avvenne in Palestina a partire dal 1948. Lo fa prendendo in prestito la voce di Amal, la brillante nipote del patriarca della famiglia Abulheja in un racconto che prende il via dall’abbandono forzato della casa dei suoi antenati di ‘Ain Hod, nel 1948, per il campo profughi di Jenin. E da quel luogo senza radici e senza tempo inizia la storia dei suoi due fratelli: il primo rapito in fasce dalle forze occupanti e diventato un soldato israeliano, il secondo che consacra la sua esistenza alla causa palestinese. Fratelli e nemici. Un dualismo che ci accompagnerà per tutte le 379 pagine del libro obbligandoci a sfogliarle con impeto, tensione, trasporto, talvolta imponendo una pausa per non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Leggendolo, mentre in alcuni passi faticavo a frenare le lacrime, non ho ancora capito se di dolore o di rabbia, mi sono tornate in mente le parole di Josè Saramago, Nobel per la letteratura portoghese, che avevo letto in suo breve scritto dal titolo “Israele e Palestina. Dalle pietre di Davide a carri armati di Golia”. Egli scrive “dal punto di vista degli ebrei, Israele non potrà mai essere sottoposto a giudizio, dopo essere stato torturato e bruciato ad Auschwitz. Mi chiedo se quegli ebrei che morirono nei campi di concentramento nazisti, che furono perseguitati per tutta la Storia, che furono trucidati nei pogrom, che marcirono nei ghetti, mi chiedo se questa immensa moltitudine di infelici non proverebbe vergogna per gli atti infami che i suoi discendenti stanno commettendo. Mi chiedo se il fatto di aver sofferto tanto non sarebbe il miglior motivo per non far soffrire gli altri”. Ora è ovvio che le parole di Saramago, pubblicate sul quotidiano spagnolo “El Pais” il 21 aprile 2002, sollevarono il risentimento di numerosi esponenti di movimenti conservatori israeliani che lo accusarono persino di antisemitismo. Sono parole forti, certamente schierate. Trovo però logico pesarle con cura, ancor più dopo aver letto in questo libro di Susan Abulhawa la storia di Amal, del padre Hassan, della madre Dalia e dei suoi fratelli Yussef e Isma’il: l’infanzia, gli amori, i lutti devastanti, il matrimonio, la maternità e l’inevitabile necessità di tramandare questa storia alla figlia, quale unico modo per preservare il suo più grande amore. Nella pagine di questo lavoro di scrittura si cela un immenso dolore, non solo per la perdita degli affetti, ma per la cancellazione delle proprie radici. La rabbia di chi legge e direttamente proporzionale alla incapacità di comprendere come il carcerato possa trasformarsi in carceriere, ma soprattutto alla consapevolezza di un occidente, che per i propri interesse politici ed economici, e forse per sopire il senso di colpa dell’Olocausto, ha continuato a girare le spalle davanti all’ingiustizia, a voltarsi dall’altra parte per fingere che nulla stava accadendo, per non vedere il campo profughi di Jenin, gli eccidi disumani nei campi di Sabra e Chatila, la tragedia del popolo palestinese. Eppure lo sapevamo tutti, sin dal 1897, anno in cui due inviati in Palestina dai rabbini di Vienna dopo il Congresso di Basilea per sondare la “terra promessa”, inviarono a casa un'eloquente telegramma che recitava: “la sposa è bella, ma è sposata a un altro uomo”. E tutto ciò che Susan Abulhawa racconta è ancora più inspiegabile se ci si è emozionati leggendo libri come “Exodus” di Leon Uris, che nel racconto della nascita dello stato di Israele testimonia sofferenze e persecuzioni degli ebrei subite ad opera dei nazisti. L’autrice di “Ogni mattina a Jenin” non è però in cerca dei colpevoli tra gli israeliani, non punta il dito su di un popolo, tutt'altro: ne parla manifestando per loro una certa pena, si limita a raccontarci invece la storia delle vittime e la forza dell’amore e della speranza che le ha nutrite. Amore e speranza di una famiglia che diventa simbolo di tutte le famiglie palestinesi, storia collettiva di oltre mezzo secolo, paradosso in cui la nascita di uno stato segna la fine di un altro. Semmai vi si cerchi una condanna, essa è diretta alle azioni e al pensiero dell’uomo in quanto tale, che tenta di giustificare il suo operato tirando in ballo una causa collettiva, ma che poi, come il padre “israeliano” di Isma’il, è costretto a convivere per l’intera esistenza con il doloroso rimorso di chi ha sottratto un figlio alla propria madre. O come il fratello della protagonista che, prima perduto e poi ritrovato, anima smarrita tra due mondi, è obbligato per l’intera esistenza ad essere consapevolmente ciò che egli non è veramente. Susan Abulhawa non ci nasconde nulla, nemmeno quella pagina di storia che riguarda la metamorfosi in terrorismo della lotta per la causa palestinese e che ci riporta alla terribile stagione dei dirottamenti e degli attentati, affidando a chi legge il difficile compito di trovare un punto d’equilibrio tra giusto e sbagliato, tra logica ed emotività, tra coscienza e sopravvivenza, obbligandoci a porci la cruciale etica domanda: io cosa avrei fatto? ”Mio fratello è stato ripudiato, incarcerato, torturato, umiliato ed esiliato perché voleva vivere la sua vita ed ereditare il patrimonio lasciatogli dalla storia. Aveva dato il suo cuore ad una sola donna, e il suo dolore per lei ha fatto tremare la terra…” (da “Ogni mattina a Jenin”)



Nella tragedia dell’esilio e nel volto disumano della guerra, riscopriamo la forza dell’amicizia, quella che unisce Amal e Huda, ancora bambine, e che resterà immutata negli anni della separazione per sbocciare come un fiore nel deserto dopo molto tempo tra due donne ormai spose e madri. C’è tutto il valore del ricordo nella perdita della terra e degli affetti, come quello odoroso di tabacco della pipa del padre Hassan che alla fanciullesca domanda di quanto possa essere grande l’amore per i propri figli li rassicura offrendosi loro “come il mare e tutti i suoi pesci, come il cielo e tutti i suoi uccelli, come la terra e tutti i suoi alberi”. La scrittura spedita e fluida dell’autrice è anche un viaggio tra le tradizioni, i rituali, l’anima di un popolo a cui per per dire grazie non è sufficiente una sola parola, ma è necessario dare al gesto un peso, quasi il valore di una benedizione: “che il Signore ti regali una lunga e felice vita”.
Se dovessi necessariamente accostare questo libro ad un altro, istintivamente sceglierei “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan in cui l’autrice narra dell’eccidio degli Armeni, non limitandosi solo al racconto di un fatto tragico, ma offrendo la testimonianza vivida di uno sterminio e della cancellazione di un popolo, della sua cultura. La Arslan come Susan Abulhawa scrive con intima passione del suo senso di appartenenza, trasmette la sensazione che prova chi è condannato a sopravvivere in un limbo. Forse il gran finale è un poco forzato in quanto a drammatizzazione del fato, ma nulla toglie al valore di una testimonianza che vale per tutte le minoranze oppresse, ma vale soprattutto come monito per la nostra coscienza, nella speranza che non ci tocchi veramente, dopo la nostra morte, incontrare il dio egizio Anubis per fargli pesare il nostro cuore.