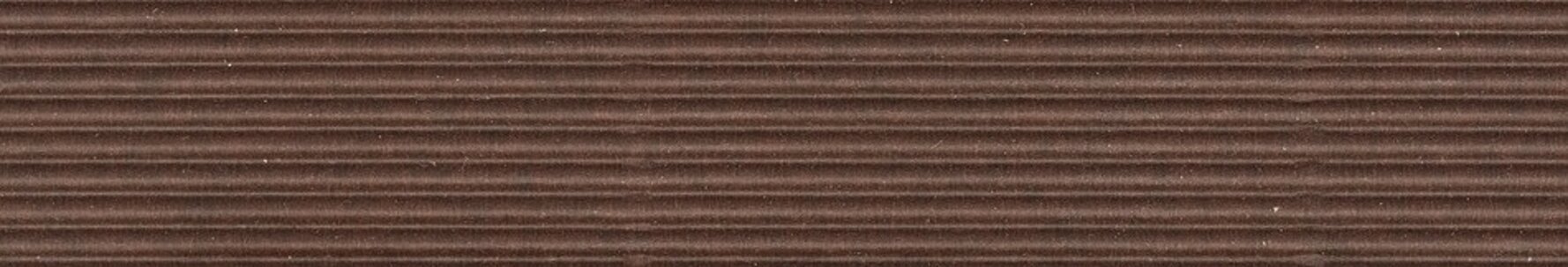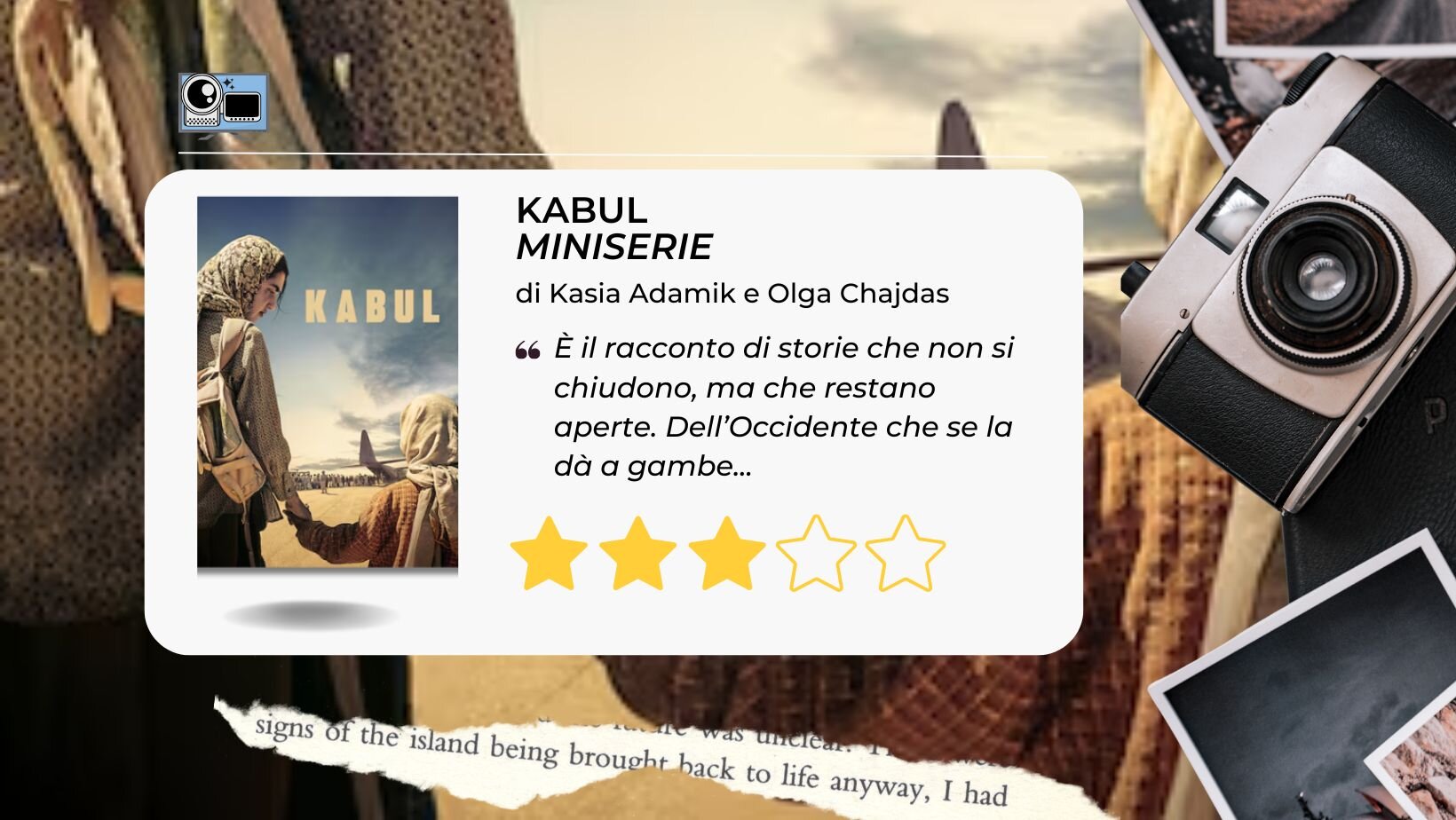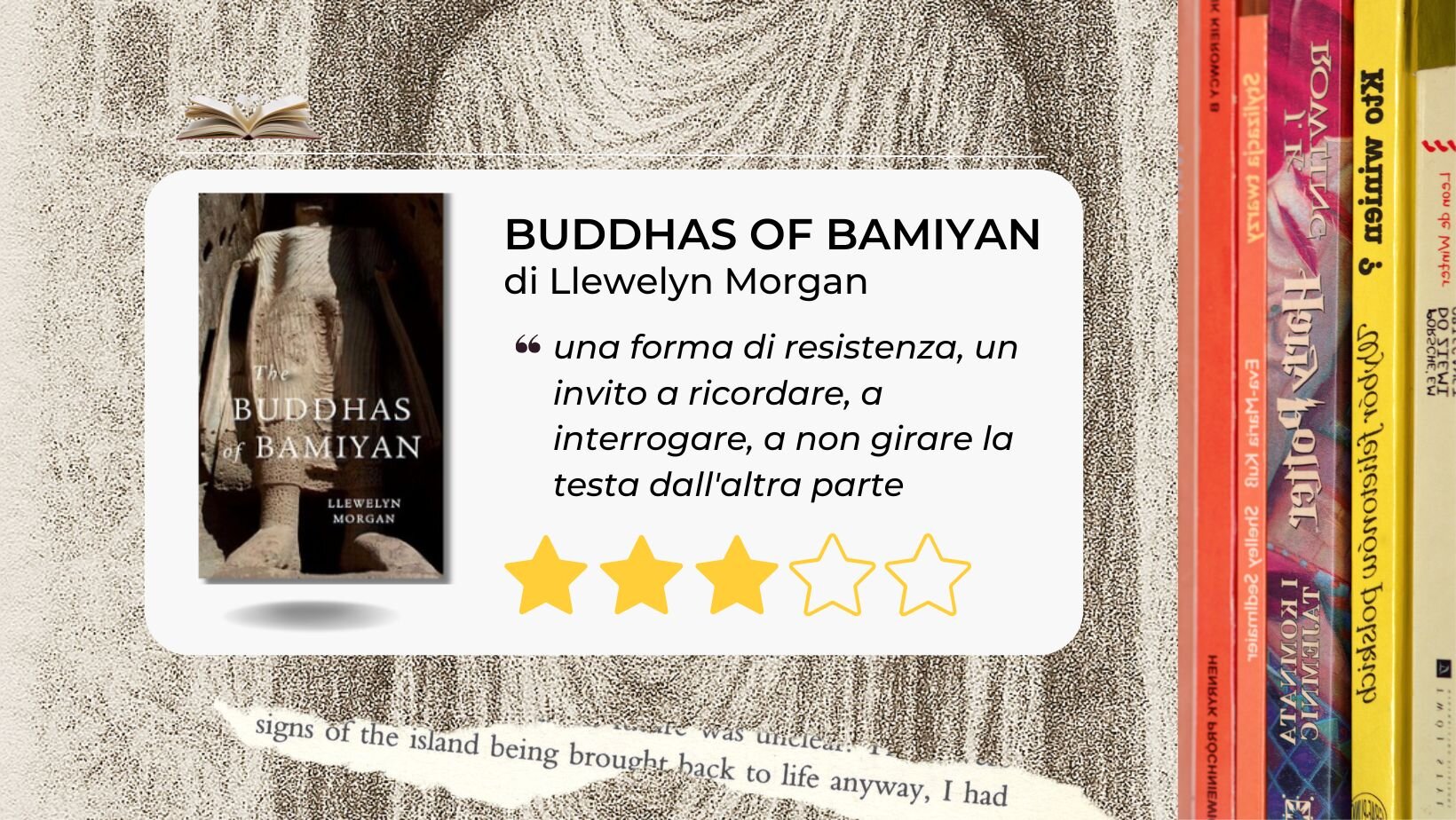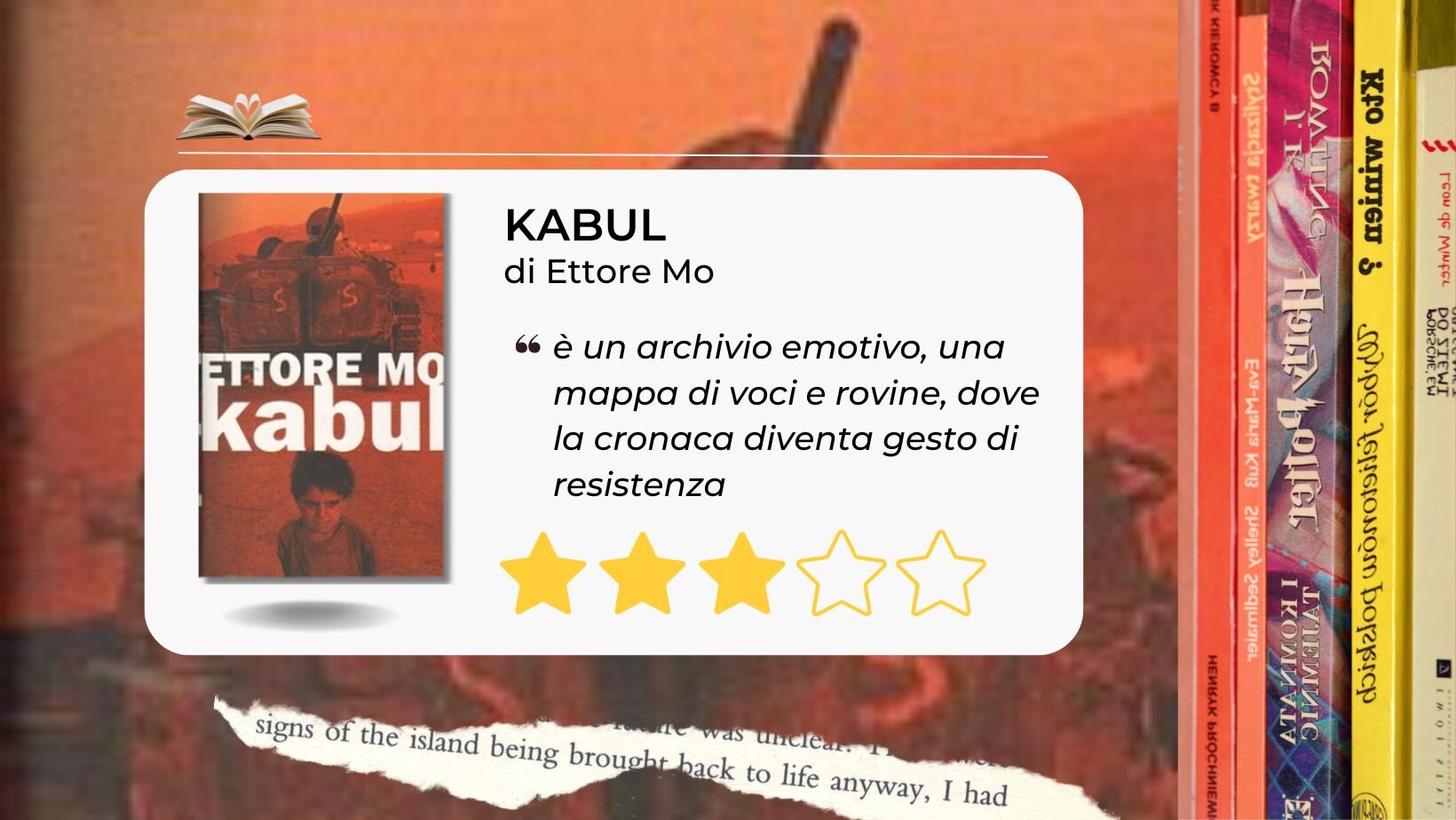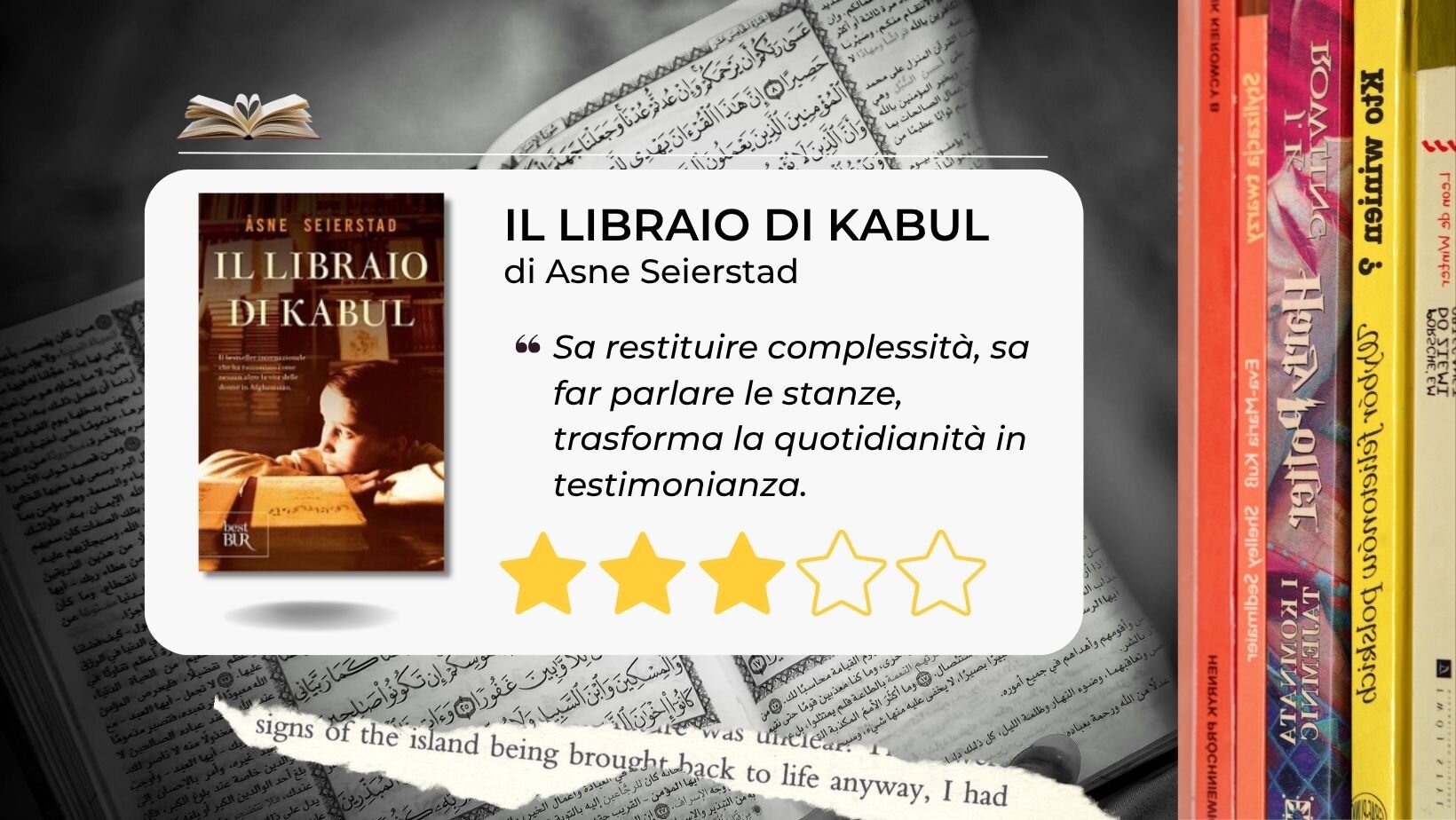Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni documentario è fatto per essere guardato.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questa serie TV
⭐ ⭐ ⭐ Buono
Ci sono immagini che non si cancellano. Il Boeing C-17 che decolla mentre civili afghani si aggrappano al carrello. Il caos all’aeroporto Hamid Karzai. I diplomatici evacuati in elicottero, come a Saigon. Il 15 agosto 2021, Kabul cade di nuovo. Ma questa volta non è una conquista militare: è una resa logistica, una ritirata precipitosa, una disfatta simbolica. L’Occidente, dopo vent’anni di presenza, lascia l’Afghanistan in fretta e senza onore. E lo fa sotto gli occhi del mondo, senza riuscire a salvare nemmeno la narrazione.
Kabul è una miniserie internazionale in sei episodi diretta da Kasia Adamik e Olga Chajdas, prodotta da Rai, France Télévisions e ZDF, trasmessa da RaiPlay. È una narrazione corale che si muove tra il 15 agosto 2021 e i giorni immediatamente successivi, quando la capitale afghana cade nelle mani dei Talebani e il mondo, ancora una volta, osserva da lontano. Rappresenta l’inizio dell’ultimo grande capitolo delle vicende afghane.
È una doccia fredda non solo geopolitica. È etica. È narrativa. È il fallimento di un progetto che si era presentato come esportazione di democrazia, ma che ha finito per abbandonare interpreti, collaboratori, donne, bambini. La “resa lampo” del governo afghano non è un mistero: è il frutto di anni di gestione clientelare, di alleanze fragili, di una fiducia mai davvero costruita. Ashraf Ghani fugge negli Emirati. I talebani entrano a Kabul senza sparare un colpo. E l’Emirato Islamico rinasce, con una bandiera bianca e una scritta nera: la shahada, testimonianza di fede. «Voi avete gli orologi, noi il tempo!» diceva un combattente talebano. E aveva ragione. Il ritiro occidentale non è solo una questione militare. È una questione di sguardo. Di come si guarda un Paese, di come lo si racconta, di come lo si lascia.
La serie non cerca di spiegare la geopolitica, ma di restituire la vertigine. Kabul non è solo una città: è un labirinto di specchi, un simbolo, un nodo, un precipizio. E la serie lo racconta attraverso storie intrecciate, afghane ed europee, che si sfiorano, si urtano, si compenetrano. Zahara e Baqir tentano la fuga, i figli Fazal e Amina prendono strade diverse per salvarsi. Giovanni, diplomatico italiano, e Vera, agente dello spionaggio tedesco, si trovano coinvolti in una corsa disperata tra evacuazioni di disperati e missioni rischiose. Non c’è un solo protagonista, ma una costellazione di prime voci. Non c’è una trama lineare, ma una tensione che cresce ad ogni puntata e la storia ti passa davanti veloce. Perché il tempo manca.
Un capitolo sta per chiudersi in Afghanistan, e si chiude alla velocità della luce. Precipita. E chi ha pensato a questa serie ha capito che non c’è tempo per offrire soluzioni, né per fare proclami. Giusto il tempo di esporre. E nel farlo, interroga. La regia è sobria, quasi documentaria, ma non rinuncia alla densità emotiva. I volti sono veri, le paure sono vere, le scelte sono vere. Purtroppo quello che lo spettatore vede è vero e il collegamento alle immagini già viste dei telegiornali è inevitabile. Anche quando la fiction prende il sopravvento, la realtà resta sullo sfondo, come una ferita che non si rimargina.
Il valore della serie sta proprio in questo: nel non cercare l’epica, ma l’umanità. Nel non raccontare la guerra, ma la fuga per la salvezza. Nel non mostrare il potere, ma la sua assenza. Kabul diventa il teatro di una resa, ma anche di una resistenza. Non quella armata, ma quella umana. Quella che si consuma negli ospedali, nei silenzi, nei corridoi dell’ambasciata, nei messaggi non letti, negli elicotteri che sembrano libellule impazzite, nei voli che non partono e che, quando partono, sono stipati oltre ogni limite.
Poi c’è l’italianità. In questa serie non è bandiera, ma presenza vera, quanto inaspettata, casuale, ma che cresce per rivendicare che una coscienza esiste e che non serve cercarla. Giovanni, il console, non è un vero eroe, ma quasi lo diventa. È un uomo che cerca di fare il possibile, in un contesto che lo supera. E in questo, la serie riesce a raccontare anche noi: il nostro sguardo, la nostra responsabilità, la nostra ambiguità. Non c’è retorica, né patriottismo. C’è una disperata volontà di aiutare.
Poi c’è il senso forte della famiglia. Quella dei padri e delle madri, dei figli e dei fratelli, che in fondo ci dice che gli afghani sono come noi e ciò che capita loro non è detto che non possa accadere ad altri. Ma anche della famiglia più grande di un popolo tormentato, fatto di volti, scelte, silenzi. È il racconto di storie che non si chiudono, ma che restano aperte. Come ferite, come testimonianze, come atti di memoria.