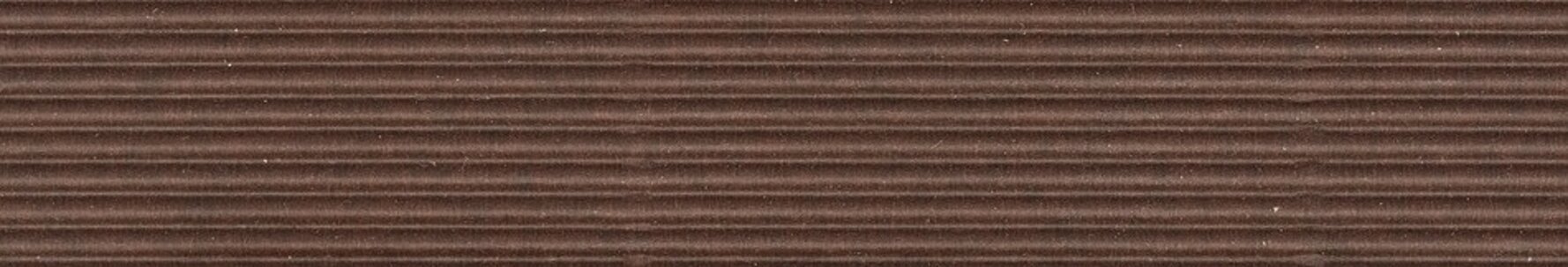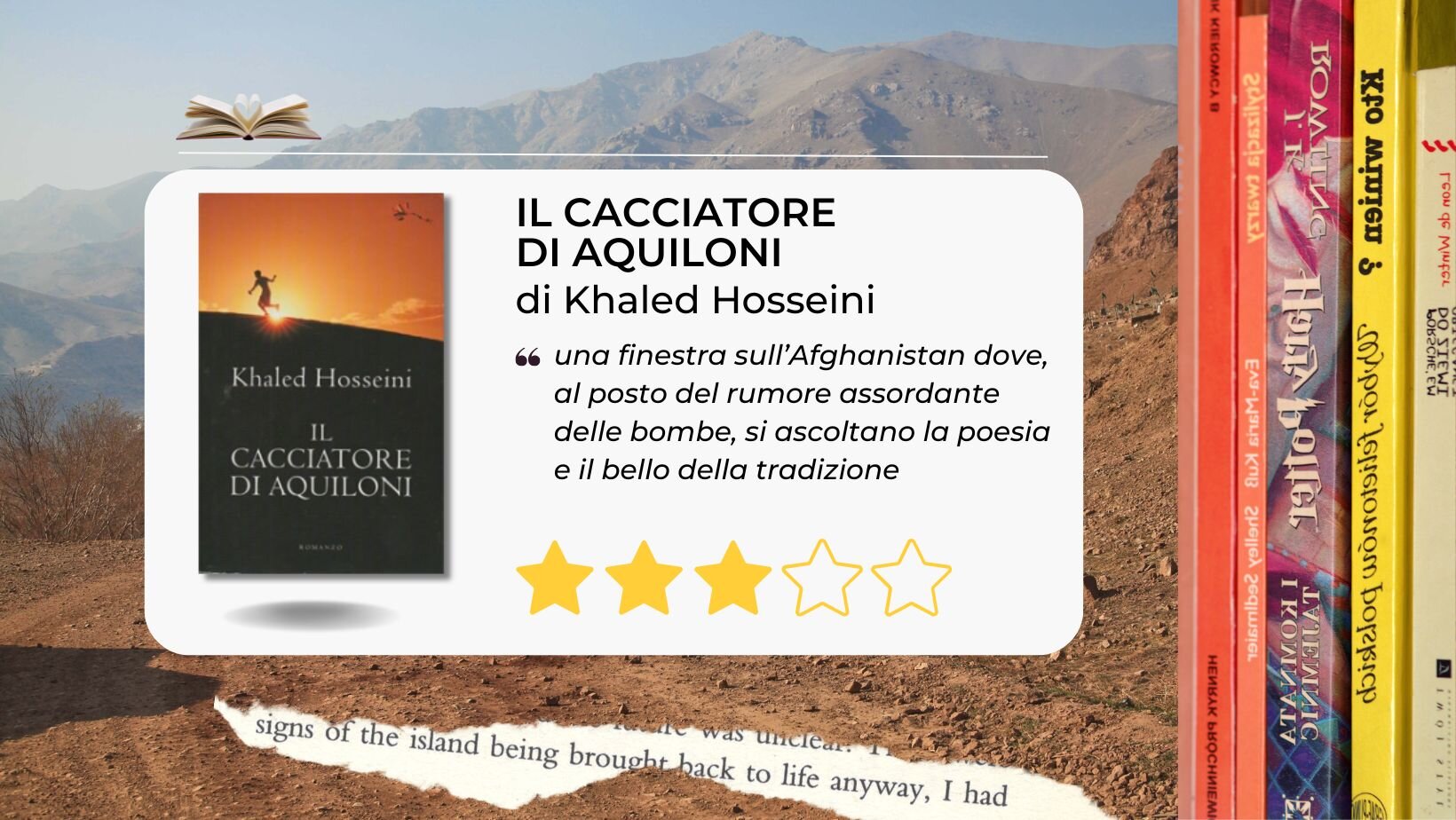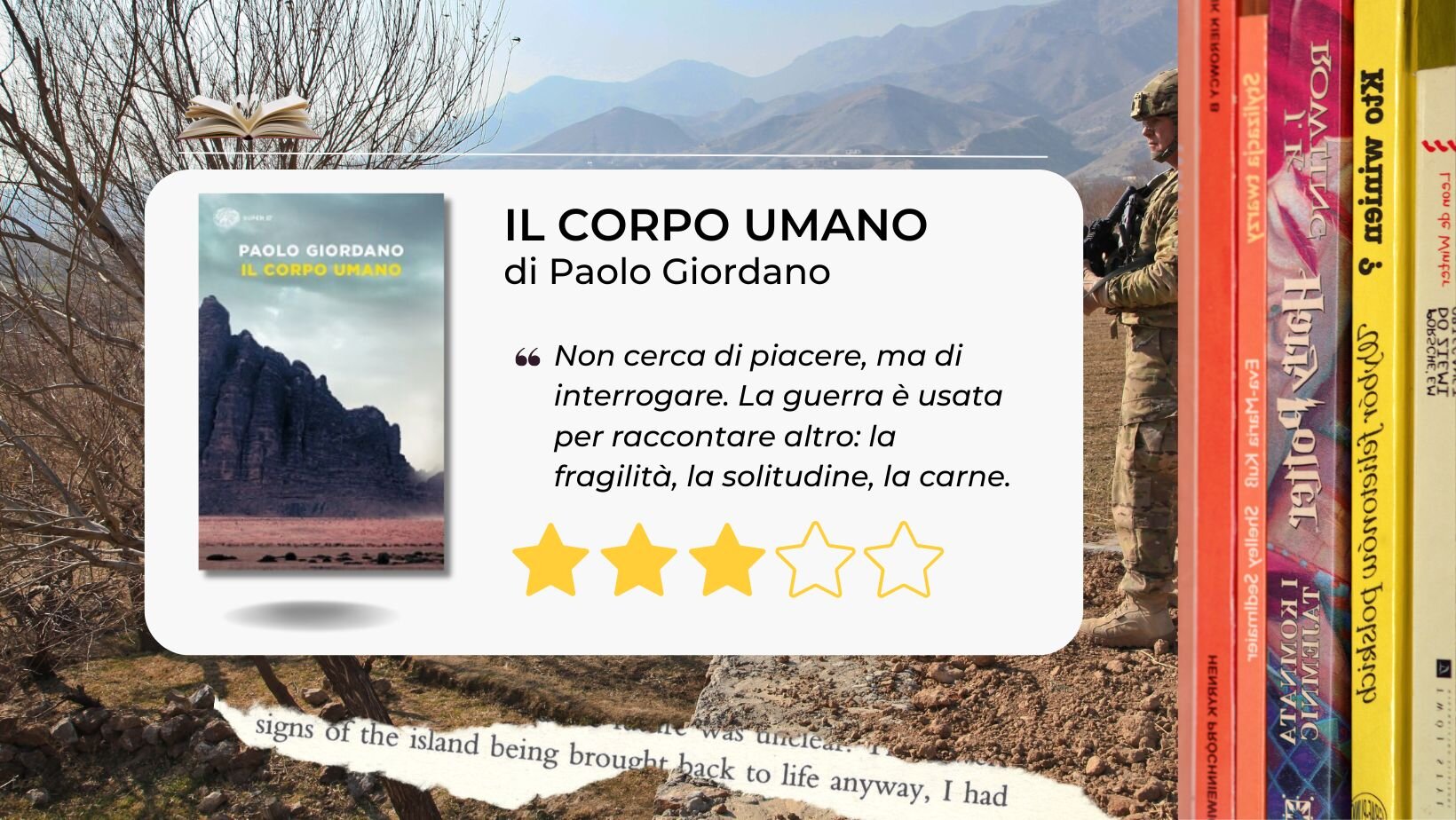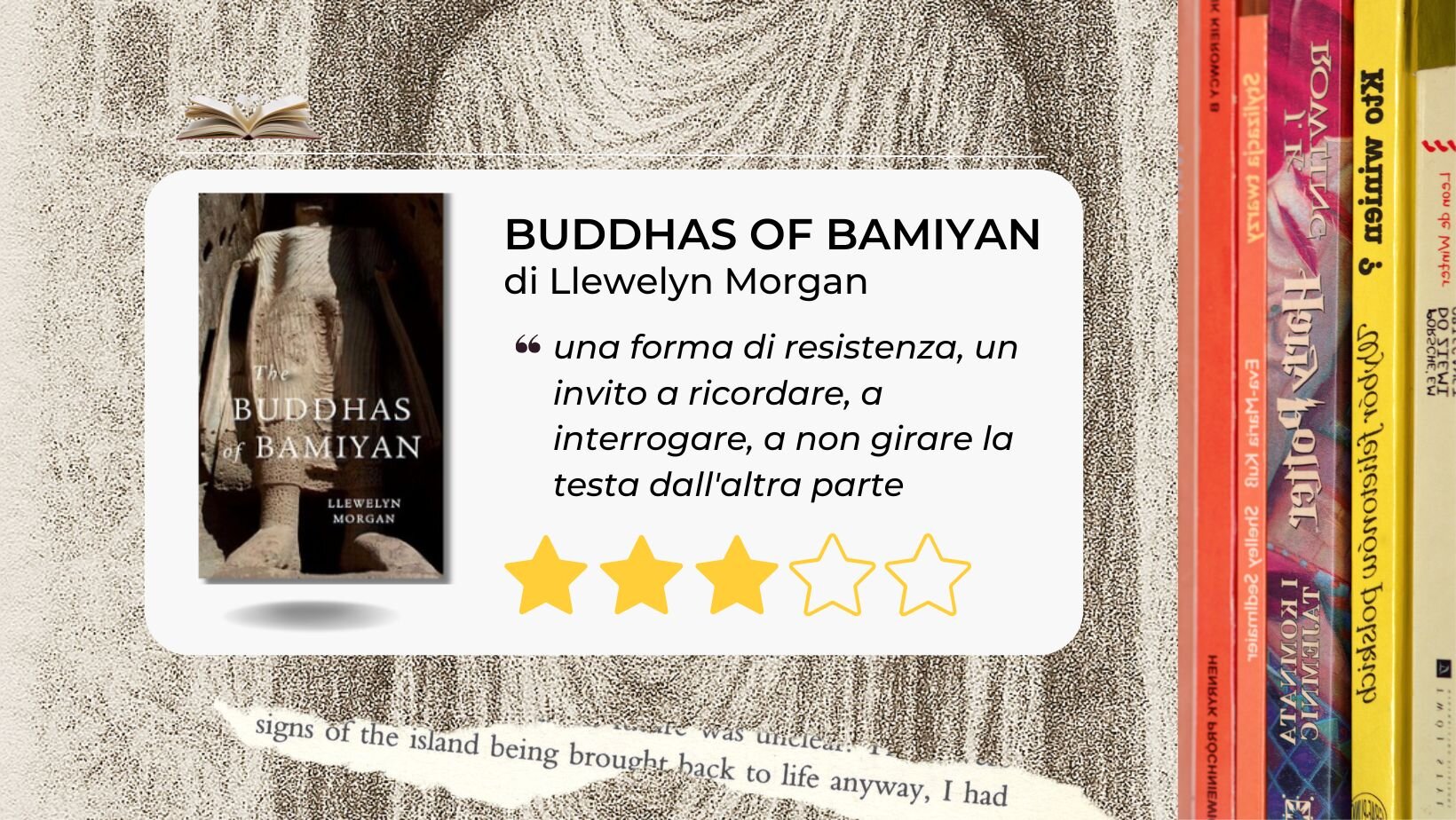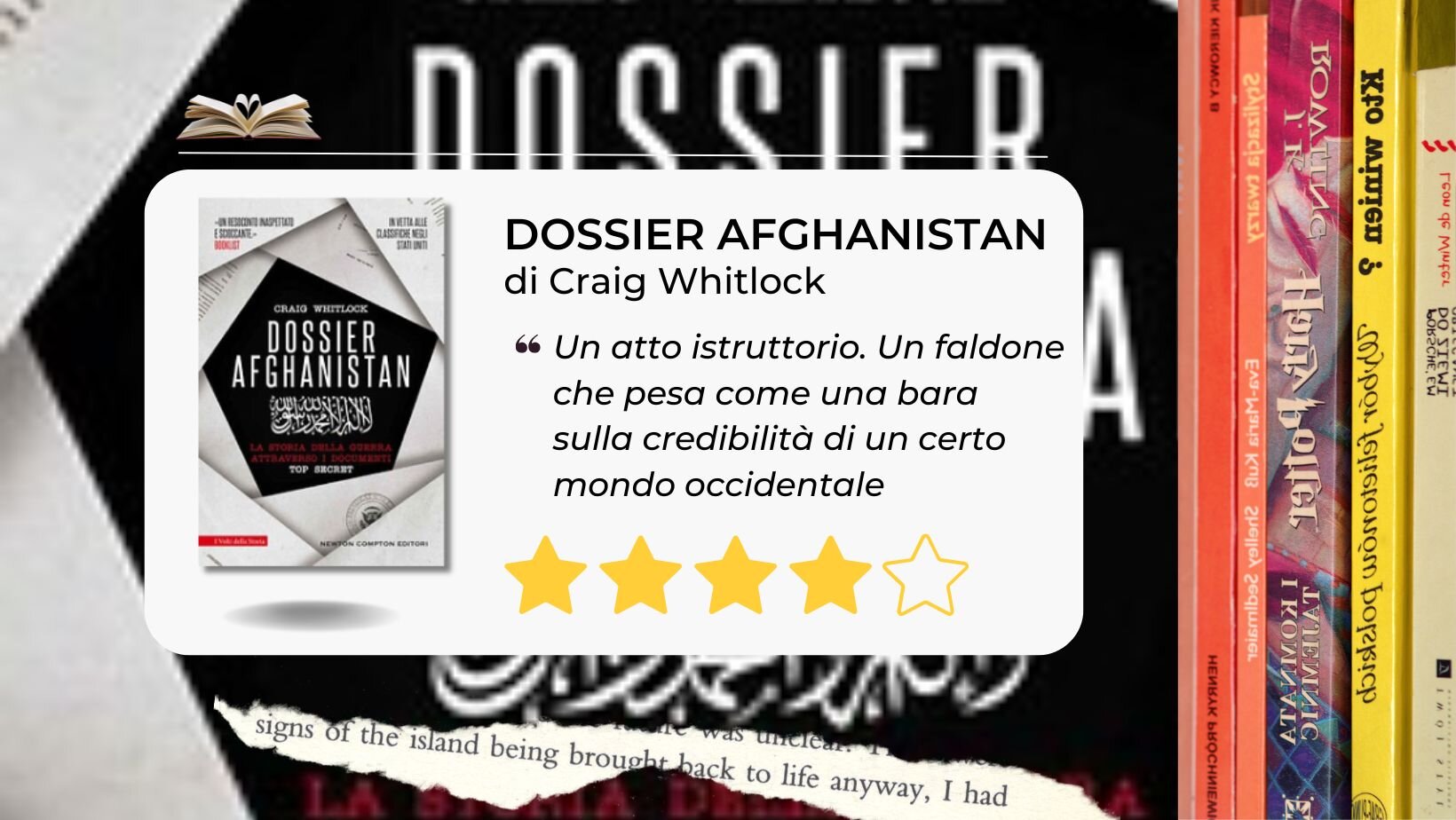Avvertenza
Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.
⭐ Sufficiente
⭐ ⭐ Più che discreto
⭐ ⭐ ⭐ Buono
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente
La mia valutazione su questo libro:
⭐ ⭐ ⭐ Buono
Parliamo di un'opera prima che ha lasciato un segno, e che ancora oggi interroga il lettore sul senso del perdono e sulla possibilità del riscatto. Perché se tra le pagine de Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini c'è tutto l'Afghanistan della guerra raccontata, la verità è che talvolta chi legge se ne dimentica, tanta è la forza dei sentimenti che vi albergano: il rimorso, l’amicizia, la memoria. In un’epoca in cui l’Afghanistan è spesso ridotto a teatro bellico o a sfondo geopolitico, Khaled Hosseini compie un gesto radicale: restituisce al Paese la sua dimensione umana, intima, lacerata. Un esordio narrativo che già contiene la cifra stilistica che lo renderà uno degli autori più letti al mondo, grazie a una scrittura limpida, emotiva, umana — e per questo capace di attraversare la storia senza mai perdere il filo dell’anima. Non è un caso se questo romanzo sia stato tradotto in oltre quaranta lingue ed abbia venduto più di 30 milioni di copie nel mondo.
La vicenda ruota attorno ad Amir, figlio di un ricco pashtun, e Hassan, figlio del servitore hazara. Le due grandi etnie della nazione. I due bambini crescono insieme nella Kabul degli anni Settanta, tra giochi, racconti e gare di aquiloni. Ma un episodio traumatico — una violenza taciuta — spezza il legame e apre una ferita che attraverserà tutto il romanzo. Amir fugge, prima da Hassan, poi dal Paese, rifugiandosi negli Stati Uniti. Ma il passato, come scrive Hosseini, “è una bestia dai lunghi artigli”. E quando una telefonata lo richiama a Kabul, Amir capisce che l’unico modo per tornare intero è affrontare ciò che ha lasciato incompiuto.
La godibilità del romanzo sta, a dirla tutta, in un gioco di ruoli vecchio come l'umanità: bianco e nero, bene e male, perfetto e imperfetto. La figura di Hassan è centrale: puro, leale, silenzioso. È lui il vero eroe del romanzo, colui che “per te, lo farei mille volte ancora”. Una frase che riecheggia tra le pagine quasi fosse un mantra, una promessa, ma anche una condanna. Amir, invece, è un protagonista imperfetto, vigliacco, terribilmente umano da volerlo abbracciare. E proprio per questo assolutamente credibile. Il suo percorso di redenzione è doloroso, ma necessario. E la via crucis, chi legge la percorre al fianco di Amir. Tra i due solisti, se proprio si volesse cercare un limite, gli altri personaggi appaiono corali, costruiti con una certa linearità, ma credo perfetti per chi nella critica evidenzia una tendenza alla semplificazione emotiva nei momenti più drammatici. Ma questo, in fondo, è l'Afghanistan, non il Portogallo, e se vuoi sopravvivere a ciò che appare — e che forse è davvero un dramma — allora è proprio il caso di “non farne un dramma”.
Il romanzo si sviluppa come un lungo flashback, con una struttura che alterna la Kabul pre-talebana, il Pakistan dei rifugiati e l’America degli esuli. Hosseini, medico e scrittore afghano naturalizzato statunitense, conosce bene questi mondi. Si affronta una narrativa informata, in cui la retorica è talmente sfumata da svanire. Meglio così. Va a buon fine quindi il tentativo di raccontare l’Afghanistan attraverso le sue ferite invisibili: le divisioni etniche, le gerarchie sociali, le colpe di tutti e di nessuno.
Ma il vero impatto del libro è culturale: apre una finestra sull’Afghanistan dove, al posto del rumore assordante dei colpi di mortaio e delle bombe, si ascoltano i momenti dell'infanzia, la poesia, il bello della tradizione. Dove alla monocromia della polvere preferisce il colore guizzante degli aquiloni, che nel romanzo diventano metafora di libertà e perdita, e sono tornati a volare anche nella coscienza occidentale. Perché se è vero che Il cacciatore di aquiloni è un romanzo che parla di Afghanistan, è altrettanto vero che parla di tutti noi. Di ciò che lasciamo indietro, di ciò che non abbiamo il coraggio di dire, di ciò che — forse — possiamo ancora riparare.
Il New York Times lo ha definito “una storia toccante e potente”, mentre il Guardian ha parlato di “un romanzo che restituisce dignità a un Paese troppo spesso dimenticato”. La verità è che è una storia di amicizia. Ma soprattutto, è una storia di memoria scritta per un mondo che dimentica troppo in fretta.
Dal libro al film
Il libro si è trasformato in un film diretto da Marc Forster. La Kabul dell’infanzia, con i suoi tetti assolati e gli aquiloni che fendono l’aria, è ricostruita con cura quasi documentaria, mentre la violenza e la colpa si insinuano nei silenzi, negli sguardi, nei non detti. Il film si muove su tre registri: l’innocenza perduta, l’esilio americano, il ritorno. E in ciascuno di questi spazi, la macchina da presa cerca il volto di Amir, il protagonista, come se volesse chiedergli: “Dove sei stato, mentre tutto accadeva?”.
La colonna sonora di Alberto Iglesias accompagna il racconto con discrezione, mentre le lingue parlate (dari, pashtu, inglese) restituiscono la complessità culturale dell’Afghanistan. Il cast, composto in gran parte da attori afghani e mediorientali, offre interpretazioni intense, in particolare i giovanissimi Ahmad Khan Mahmidzada (Hassan) e Zekeria Ebrahimi (Amir bambino), capaci di reggere il peso simbolico della storia. Limiti: alcune semplificazioni narrative erano inevitabili, e il finale rischia di chiudere troppo ordinatamente una vicenda che nel libro restava più ambigua.
Il film, tuttavia, conserva il cuore del romanzo: il senso di perdita, il peso della memoria, la possibilità del riscatto. Gli aquiloni, simbolo di libertà e infanzia, tornano a volare anche sullo schermo, in una Kabul che non smette di chiedere verità.